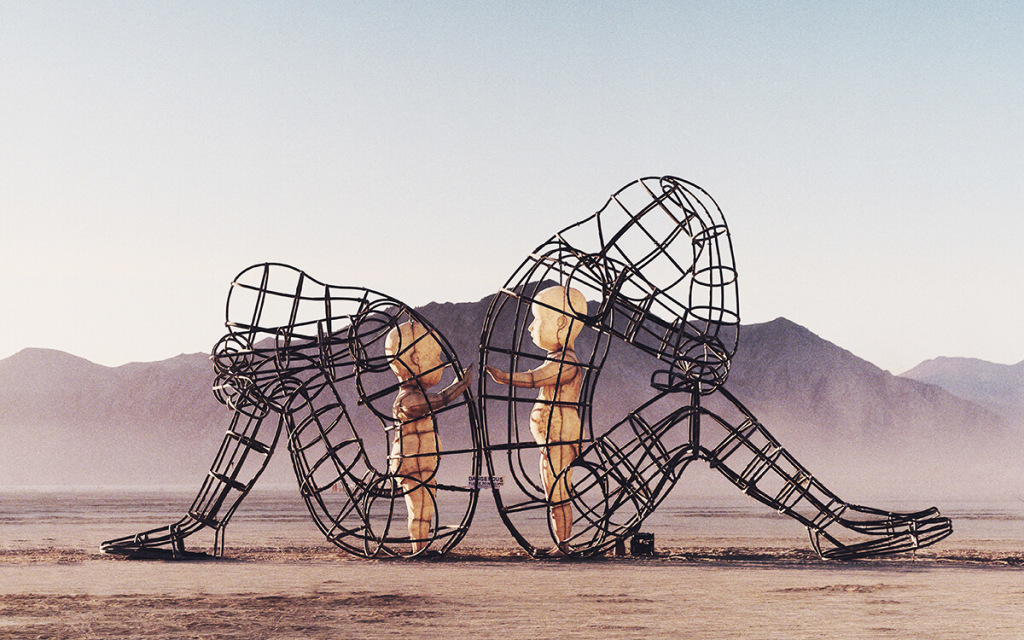Quando i miei clienti iniziano a rivolgersi a me come fa mia mamma quando nel mezzo di una giornata qualsiasi mi chiama e sbrigando velocemente la pratica dei convenevoli mi chiede “Perché mi dice errore?” (riferendosi, vado a intuito, a qualcosa che le sta andando storto a rotazione sul tablet, lo smartphone, il PC, whatever, ma che non ritiene importante specificare perché per lei la soluzione ce l’ho sicuramente) beh, allora penso di avercela fatta.
Avrei potuto scrivere “allora penso di averli in pugno”, ma non sarebbe stato altrettanto corretto. Il mio farcela significa che sono riuscita a costruire quel macchinoso, affascinante e semplicemente complicato rapporto che va sotto il nome di fiducia. All’Università (a memoria mi sa che qui sopra l’avevo già raccontato) durante l’ultimo anno ho frequentato un corso eccezionale durante il quale abbiamo analizzato i rapporti di fiducia all’interno dei film di Hitchcock (per due anni ho studiato cinema, ebbene). Quel che abbiamo scoperto allora, è stata una cosa sorprendente: la fiducia è una e solo una, ma ha la rara se non unica capacità di esprimersi, costruirsi e adattarsi in modi sempre diversi.
Il fatto più surreale è che la fiducia dovrebbe per sua natura essere istintiva, quasi inconscia, muovere su basi assolutamente irrazionali (ma non per questo meno giuste). Nella realtà, però, la fiducia ha bisogno di prove e perché nasca, cresca e “ci sia” quanto più poderosamente possibile, è necessario renderle il terreno accogliente, coltivarla e non dimenticarsi mai che ha continua necessità di cure.
Tutto bene, fino a qui. Se mai hai avuto una storia d’amore sai quanto queste cose siano vere e abbiano bisogno di tempo. Stare insieme è un lavoro, qualcuno un giorno mi ha detto. Aveva ragione, anche se ha dimenticato di aggiungere che un lavoro ancora più faticoso è quello che devi svolgere quando ad avere un rapporto (professionale) sperabilmente continuativo dovete essere tu e – come nel mio caso – i tuoi clienti.
Ci ho messo qualche anno per capire che, per me, il modo migliore di lavorare era quello di portare quella che sono io in ogni singolo progetto. Ciò significa che il sano distacco che molti professano essere la via migliore per il successo professionale qui non è mai pervenuto. Va da sé che, prima ancora di mettermi a scrivere per un cliente, a preparargli un piano editoriale e a imbastire un progetto in generale, io con questo cliente ci debba parlare, lo debba conoscere e ci debba entrare – anche minimamente, perlomeno all’inizio – in sintonia. Con il tempo ho imparato a fare una richiesta chiara, in fase di contrattazione (non intendo economica), ossia “Fidatevi di me. O perlomeno mettetevi nel mindset (N.B. non dico mindset di solito, ma adesso non mi viene un altro termine) di potervi fidare di me. Farò in modo che questa cosa accada quanto più naturalmente possibile, ma remiamo entrambi nella stessa direzione, così per non andare necessariamente a sbattere contro l’iceberg della delusione”.
A volte capita il colpo di fulmine: ci si sta simpatici, ci si trova bene, si parla la stessa lingua, si sta sulla stessa lunghezza d’onda e via di frasi fatte sul tema.
Ma molto spesso il rapporto tra consulente e cliente è fatto di alti e bassi: aspettative non attese (e via che la fiducia si abbassa un po’), entusiasmi da fuochi d’artificio (“mi fido di te così tanto che ti prometto lavoreremo sempre insieme”), equilibrio nel rapporto (“ho scelto te perché mi fido e quindi ti pago perché sia tu a dirmi cosa è meglio fare e non il contrario”).
Ma la fiducia è una strada a doppia corsia. Spesso si tende a pensare che la direzione più forte sia quella da azienda a consulente. Forse è vero. Forse, come dicono in tanti, ad avere il coltello dalla parte del manico è chi tiene i cordoni della borsa. Non so, ma a me pensarla solo così torna fino a un certo punto. Il mio lavoro (parlo sempre per me, ovviamente) si basa innanzitutto sulle mie competenze, sul mio saper lavorare (ne ho scritto anche qui), ma poi anche sul feeling che riesco ad avere con il progetto che sto seguendo. E il progetto è fatto dalle persone che lo guidano e che lo rappresentano e con le quali ho a che fare.
Sono fortunata: ispiro naturalmente fiducia (e poco servirebbe dire che qui è ben riposta perché nel mondo della fiducia le parole sono mute e parlare sono invece, appunto, le prove) e tendo naturalmente a fidarmi. Per questo, con me, è raro che inizialmente ci siano degli attriti. Capitano quando sul piatto si iniziano a mettere argomenti che poco hanno a che fare con un reciproco scambio di valori e visioni, ma si dirigono più che altro verso l’imposizione e l’affermazione della propria posizione fine a se stessa (in soldoni “Mi fido di te nella misura in cui fai quello che ti dico di fare” oppure “È inutile che mi sbatta a mettere in piedi un rapporto di fiducia con te perché tanto in alto alla gerarchia ci sto io e io decido”).
Un paio di esempi: un giorno ho ricevuto, da parte del mio referente all’interno di un’azienda con cui collaboravo, una mail dai toni asprissimi, a memoria “Hai fatto una cazzata, smettila di scrivere le tue motivazioni, fai quello che ti dico”. Non mi vergogno di dire che ho pianto molto. Al di là del fatto che avesse o meno ragione, quei toni, ma soprattutto quel contenuto hanno ridotto in polvere una volta per tutte la fiducia che IO avevo in LORO. A questo si è aggiunta l’immensa delusione dell’aver scoperto che non ero (più) una persona nella quale veniva riposta fiducia. In quel momento sono venuti meno tutti i (miei) presupposti perché la collaborazione potesse continuare. Con quell’azienda non lavoro più. A niente sono valse le raccomandazioni di chi mi diceva “Tieni duro, è lavoro”. Perché, almeno per me, il lavoro è prima di tutto fiducia e senza l’una è difficile che ci sia l’altro.
Qualche anno fa, dopo una collaborazione durata anni (tipo 7, mica poco) capisco di essere finita in quel fastidioso meccanismo per cui tu, consulente esterno, inizi a essere superfluo, ma che questa cosa a capirla ci arrivi da solo. Nessuno te lo dice anche se intorno a te inizia una danza – per la verità molto divertente – di persone che tentano di capire come fai a fare quella cosa, come sei riuscita a ottenere quel risultato, e così via. In quell’occasione, anni fa, mi sono incazzata parecchio. Mi sarebbe piaciuto sentirmi dire “Non ci servi più per questo e quest’altro motivo, ma ci piacciono le cose che fai: ce le insegni?”. Avrei detto di sì, come spesso ho fatto. Condividere la mia conoscenza è per me un valore e non ho paura di farlo. Un po’ perché sono sicura di quel che so fare, ma molto di più di come lo so fare. E questa è una cosa solo mia che condividere è impossibile anche volerlo. Il mio tesoro l’ho già trovato ed è in salvo: se prendi qualcosa da me non la stai “rubando”, ma stiamo imparando a usarla insieme.
Concludo questo lunghissimo post (giuro): nessuno è un santo (e io per prima non lo sono), ma la fiducia ha bisogno di correttezza. Di parole chiare, di trasparenza. Non ha necessità di assenso obbligato. Ti fideresti mai di qualcuno che ti dice che hai sempre un aspetto meraviglioso anche nel pieno di un’influenza che non ti lascia tregua? Sicuramente no. Per questo dire sempre di sì al tuo cliente “per tenerlo buono” è una pratica furba nel breve periodo, ma miope e inutile nell’ottica di un rapporto che si vorrebbe far durare il più a lungo possibile. Ti dico le cose come stanno, senza paura che tu ti possa offendere, ma solo con lo scopo di farle migliorare. E io, che mi impermalosisco quando mi dicono che ho un aspetto orrendo nel pieno di un’influenza che non mi lascia tregua (cit.), mi fido del riscontro del mio cliente, anche quando non è come vorrei e mi spinge quindi a fare meglio e imparare un po’ di più.
A fidarmi degli altri, e prima di tutto, di me.